0CIO
Osservatorio Civico su casa e residenzialità
Canoni concordati (Patti territoriali)
Contratto di affitto in cui il canone mensile non è libero, ma stabilito in base a specifici “accordi territoriali” che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di inquilini e di proprietari e il Ministero dei Lavori Pubblici. Nel Comune di Venezia tale accordo è stato rinnovato il 28 marzo 2018. In generale, questi contratti sono vantaggiosi sia per l’inquilino poiché il canone è inferiore al prezzo di mercato, sia per il proprietario che gode di alcune agevolazioni fiscali. (link: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali text: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali )
Città storica
I sestieri veneziani inclusa l'isola della Giudecca.
Città insulare
La città storica + l'estuario e le isole minori.
Terraferma
Il territorio non insulare del Comune di Venezia.
Comuni ad alta tensione abitativa
Sono una serie di comuni, individuati per legge e in base a delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nei quali è presente un forte disagio abitativo. Tra i Comuni ad alta tensione abitativa vi sono tutte le maggiori città italiane e i capoluoghi di provincia. Proprio in ragione del disagio abitativo, si prevede che ai proprietari che concludono contratti di locazione a canone agevolato o concordato siano concessi significativi benefici fiscali (cedolare secca al 10%).
E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)
È costituita da alloggi il cui canone di locazione è commisurato al reddito delle famiglie locatarie. Vi si accede tramite bando comunale che ne identifica i criteri di accesso e relativa graduatoria. La proprietà di tali alloggi è di Enti o Amministrazioni pubbliche mentre la gestione può essere affidata a soggetti terzi.
I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane
Tra gli enti socio-assistenziali rivolti alla persona più importanti del Veneto. Gestisce strutture socio-sanitarie, residenziali, centri servizi rivolti ad anziani, di riabilitazione, comunità alloggio per ragazzi e ragazze con difficoltà famigliari e di disagio giovanile, ecc. I.P.A.V. è proprietaria di un ingente patrimonio disponibile, derivante da lasciti e donazioni, costituito da 587 immobili a destinazione abitativa e 211 con destinazione diversa (negozi, alberghi, magazzini, …) localizzati in massima parte nella Città Storica di Venezia. Questi immobili sono locati con contratti del tipo libero o conformi agli accordi territoriali. Le nuove assegnazione di abitazioni sfitte sono decise attraverso gara a base d’asta al massimo rialzo. La redditività lorda degli immobili del patrimonio disponibile di I.P.A.V. è pari complessivamente a circa dieci milioni di euro annui (dato aggiornato al 2021).
ISEE-ERP
Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): introdotto da legge regionale determina l’accesso, la permanenza e il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi ERP.
Legge speciale per Venezia
Con questo termine si indica, in modo generico, un complesso di interventi legislativi “speciali” che, a seguito dell’alluvione del 1966, sono stati approvati nel tempo con il fine di perseguire la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Per quanto concerne la casa e la residenzialità, è particolarmente rilevante la legge n. 798/1984 (seconda legge speciale dopo la prima del 1973) che introduce importanti investimenti per l’edilizia residenziale e contributi ai privati per il risanamento di immobili di proprietà, con destinazione abitativa vincolata per alcuni anni.
Locazioni brevi turistiche
Sono una tipologia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che coniuga lo scopo turistico (l’abitazione cioè non viene affittata per risiederci stabilmente) con la brevità della relativa durata (almeno inferiore a 30 giorni, ma spesso limitata a pochi giorni). Si tratta della tipologia contrattuale più frequente con la quale le case a Venezia sono affittate ai turisti. La sua grande diffusione è legata all’avvento delle piattaforme di home-sharing; la più nota fra queste è Airbnb (nata nel 2008). Non essendo una tipologia ricettiva vera e propria, le locazioni turistiche brevi non ricadono nella competenza legislativa regionale in materia di strutture ricettive (diversamente da B&B, affittacamere, ecc.), ma in quella statale.
Equo canone
Con la legge L.392 del 1978 si introdusse una calmierazione dei canoni di affitto: i contratti stipulati non potevano superare il cosiddetto “equo canone”, un valore stabilito sulla base di alcune caratteristiche dell’alloggio locato, come il tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), il livello di piano, lo stato di conservazione, la zona della città, l'accesso o meno al trasporto pubblico locale, le dimensioni della città. La legge fu abrogata nel 1998 e da allora i canoni di affitto privati sono completamente sottoposti al mercato.
Un dibattito surreale
A proposito della cedolare secca

Il dibattito pubblico e politico di questi giorni sull’“aumento delle tasse” sugli affitti brevi ha toccato vette insuperabili di surrealismo, con affermazioni mistificatorie della realtà che hanno ricevuto ampia e pressoché incontrastata diffusione non solo presso molte forze politiche (alcune delle quali hanno evidentemente l’interesse ad accattivarsi una categoria di riferimento dell’elettorato), ma pure presso la più generale opinione pubblica.
Il (de-)merito va prevalentemente – e ci dispiace rilevarlo – alla stampa italiana che, dismesso il proprio compito di critica e di verifica e riscontro di dati, fatti e fonti, limitandosi, come sempre più spesso avviene, a trascrivere le dichiarazioni di qualche esponente politico o le veline delle associazioni di gestori degli affitti brevi. Non si spiega altrimenti il senso di titoli assurdi come “Affitti brevi, cosa cambia con la manovra: la nuova cedolare secca (al 26%) pesa 1.300 euro a famiglia, i conti” (Corriere della Sera), che sembrano sottointendere che tutte le famiglie italiane avranno un aggravio di 1.300 euro, come fossimo tutti proprietari di più case e affittassimo allegramente ai turisti (come si sia arrivati a stimare 1.300 euro di aggravio resta poi un mistero…). Oppure si veda la minaccia, diffusa indistintamente su tutti i quotidiani, di un calo dell’offerta, di un aumento dei prezzi e dell’esplosione del nero.
La ragione di questa uniformità nelle “analisi” è presto detta: sono sostanzialmente affermazioni di AIGAB (Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi), che imperversa un po’ ovunque con il suo presidentissimo Marco Celani, basate su elaborazioni ed esiti di studi della stessa AIGAB. Per carità, è giusto sentire tutte le campane, ma da giornalisti professionisti ci si attenderebbe un approfondimento critico, non un copia-incolla dei vari comunicati stampa.
Prendiamo giusto alcune delle (tante) verità “inconfutabili” di AIGAB.
- AIGAB: In Italia ci sono 35,2 milioni di case e 9,6 milioni seconde case non utilizzate.
Critica: Sì, ma dove? Non ha alcun senso mettere insieme tutti gli immobili vuoti (sommando le grandi città, le medie, i paesi, le tante aree interne spopolate), dato che gli impatti negativi degli affitti brevi si concentrano in città o aree circoscritte. - AIGAB: Soltanto l’1,4% del totale delle abitazioni esistenti in Italia è promosso online con finalità di affitti brevi (502k, dato ad agosto 2025).
Critica: Bene, ma vale la stessa osservazione di cui sopra: si confrontano grandezze (totale delle case e totale degli affitti brevi) che non ha alcun senso confrontare, perché gli affitti brevi sono concentrati in poche città e poche aree. Avrebbe più senso confrontare le case potenzialmente idonee ad essere destinate all’affitto di lunga durata nei centri turistici e gli affitti brevi. Cosa che AIGAB & co. si guardano bene dal fare (Non bisogna essere degli scienziati poi per capire che, nel totale delle case, ci sono anche quelle di proprietà abitate dai proprietari, che in Italia sono oltre il 70% degli italiani!). - AIGAB: il 30,4% delle case messe a reddito con affitto breve è frutto “di un’eredità situata in località dove i proprietari non hanno interesse a investire, ma che cercano comunque di mantenere e valorizzare” (il dato è frutto di un’indagine presso i clienti di Aigab…).
Critica: Ma se davvero è una località dove non c’è interesse ad investire, perché dovrebbe “fruttare” l’affitto breve e non un affitto di lunga durata?
Interrompiamo questa galleria degli e/orrori.
Ma il punto centrale di tutta questa surreale vicenda è che non si comprende perché i redditi da affitto breve debbano godere – come fanno – del regime fiscale di favore della cedolare secca. Intendiamo non solo al 21%, ma in generale, anche al 26%. Perché un proprietario che affitta la sua seconda casa ai turisti deve poter scorporare il reddito da affitto breve dal suo reddito da persona fisica?
La cedolare secca – pare necessario ricordarlo – è nata come regime fiscale di favore per spingere i proprietari a dichiarare al Fisco i redditi da locazione, in un settore in cui era larghissimo il ricorso al nero. Ci sono diversi studi, anche della Banca d’Italia, che tuttavia mettono in discussione sia l’efficacia, sia l’equità di una siffatta misura. Non solo gli esiti sul piano dell’emersione sarebbero controversi, ma anche sotto un profilo di giustizia sociale non si comprende perché il proprietario, povero o ricchissimo che sia, debba poter pagare sempre la stessa aliquota sul reddito da locazione, senza che questo reddito vada a confluire nel reddito da persona fisica, con l’applicazione delle rispettive aliquote.
Un’ulteriore giustificazione della cedolare secca potrebbe essere, per quanto concerne i c.d. canoni concordati, per i quali è fissata al 10%, quella di favorire la conclusione di contratti a prezzi più contenuti.
Ma tutto ciò non vale per gli affitti brevi.
Non regge la minaccia delle associazioni della crescita del nero: gli strumenti per scovare chi fa attività di affitto breve in nero sono sempre di più e sempre più pervasivi, grazie anche a una serie di interventi dell’Unione europea. Ma non regge soprattutto il discorso su un piano etico: perché privilegiare con la cedolare secca chi affitta a turisti, e fa proventi in genere molto più alti di un normale affitto?
La verità è che, se proprio si vuole ripristinare una tassazione più giusta, anche rispetto alle differenze che corrono tra i diversi proprietari-locatori, la soluzione è una: cancellare la cedolare secca per i redditi da affitto breve.
Il reddito da affitto breve confluirà nel reddito generale della persona fisica del proprietario e si applicherà l’aliquota IRPEF corrispondente: fino a 28.000 euro: aliquota del 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: aliquota del 35%; oltre 50.000 euro: aliquota del 43%.
Non sei ricco ed integri il tuo magro reddito con l’affitto di una piccola seconda casa? Pagherai secondo la tua aliquota, proporzionalmente molto meno del ricchissimo che affitta la seconda casa in centro a Milano, che invece sinora ha pagato esattamente la tua stessa aliquota (del 21%!). Alla faccia dell’equità e dell’integrazione del reddito!
Insomma: è serio sostenere che le cose debbano essere lasciate così come sono?
-
27 January 2026
Altri due conti (e un fumetto) sull'ex Scalera - ex Trevisan

-
23 January 2026
Bandi ERP, quando l'ideologia provoca disastri - parte quarta
La sentenza della Corte d'Appello di Venezia

-
22 January 2026
Bandi Erp, quando l'ideologia provoca disastri
Parte terza: la sentenza della Consulta n.1/2026
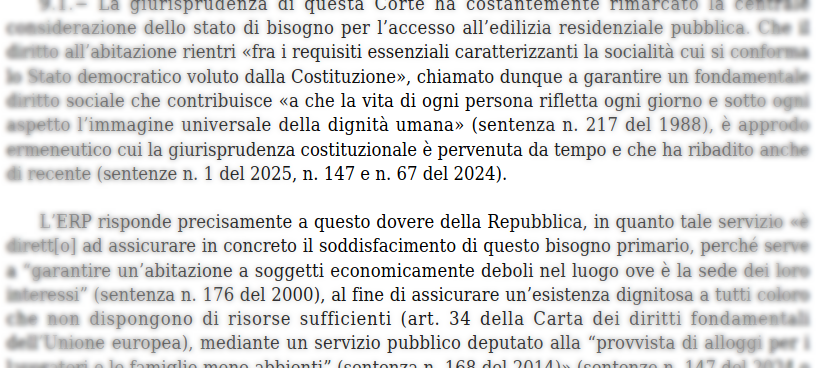
Social Housing/Edilizia convenzionata o Edilizia Residenziale Sociale
Si tratta di progetti che si collocano tra l’edilizia popolare e il mercato immobiliare libero destinati alla fascia di popolazione che non può accedere ai bandi ERP ma che non riesce ad acquistare o sostenere un canone d’affitto di un appartamento a prezzi di mercato. Il social housing è definito dal D.M. 22 aprile 2008.